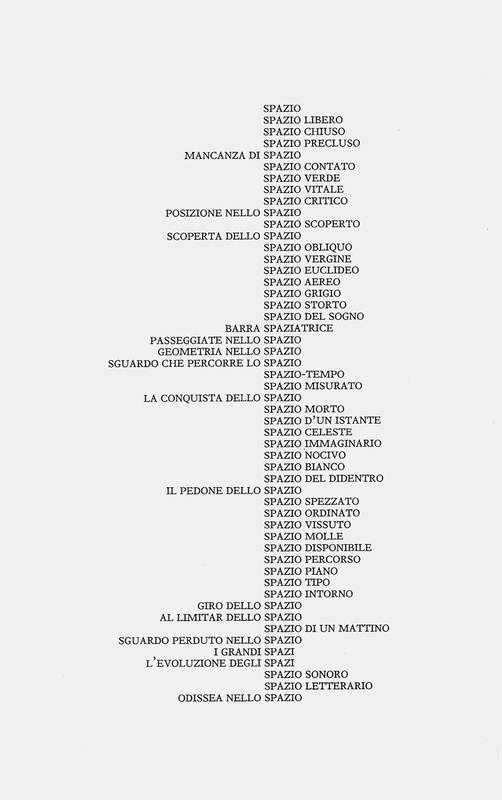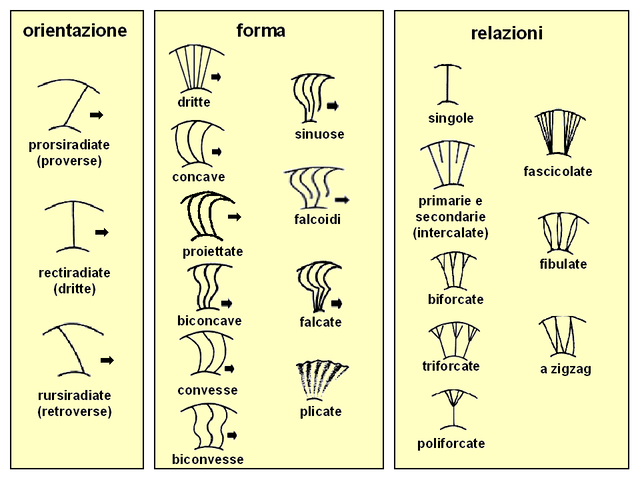Testuale
La poetica dello spazio, Gaston Bachelard
“Se il rumore delle automobili diventa più insostenibile, mi ingegno a ritrovarvi la voce del tuono, di un tuono che mi parla, mi sgrida. (…) Il mio divano è una barca perduta sui flutti, questo sibilo improvviso è il vento tra le vele. (…) Dormi malgrado la tempesta. Dormi nella tempesta. Dormi nel tuo coraggio, felice di essere un uomo assalito dai flutti.”
G. Bachelard, La poetica dello spazio, trad. it. p. 56
“Se il rumore delle automobili diventa più insostenibile, mi ingegno a ritrovarvi la voce del tuono, di un tuono che mi parla, mi sgrida. (…) Il mio divano è una barca perduta sui flutti, questo sibilo improvviso è il vento tra le vele. (…) Dormi malgrado la tempesta. Dormi nella tempesta. Dormi nel tuo coraggio, felice di essere un uomo assalito dai flutti.”
G. Bachelard, La poetica dello spazio, trad. it. p. 56
Geografie / Paesaggi
Domus de Janas
Le Domus de Janas sono strutture sepolcrali preistoriche costituite da tombe scavate nella roccia tipiche della Sardegna prenuragica. Si trovano sia isolate che in grandi concentrazioni costituite anche da più di 40 tombe. Ne sono state scoperte più di 2.400, circa una ogni chilometro quadrato, e molte rimangono ancora da scavare. Sono sovente collegate tra loro a formare delle vere e proprie necropoli sotterranee. I corpi erano depositati in posizione fetale accanto agli averi che si credeva fossero necessari per il viaggio verso l’aldilà. Molti credono che i defunti venissero posizionati in quel modo solo dopo essere stati lasciati all’aperto e, quando di loro rimaneva solo lo scheletro, venivano depositati nelle caverne.
Il termine di lingua sarda domus de janas è stato tradotto in "case delle fate".
Le janas sono infatti creature immaginarie della tradizione popolare sarda: donne incantatrici di minuscola statura che abitavano le Domus de Janas, scavate grazie alle loro forti e lunghe unghie. Sono le protagoniste di svariati racconti popolari della Sardegna, dove non sempre vengono descritte come fate, bensì anche come streghe, maghe e vampiri. Si dice fossero creature per niente spirituali, ma demoni nel senso greco del termine daimon, ovvero esseri a metà strada fra il mondo umano e quello divino.
Le janas sono conosciute con una numerosa varietà di termini, caratteristica questa propria di molti altri personaggi fantastici isolani che rispecchia i particolarismi locali e la fervida immaginazione di chi visse e vive la terra sarda.
A Oniferi così, come a Nuoro, le janas erano streghe o maghe dannose per gli esseri umani. A Fonni le leggende sulle janas raccontano di esseri minuscoli sia di sesso femminile che di sesso maschile. Una delle loro peculiarità era la bellezza e venivano descritte come incantatrici. A Belvì si narra che le janas fossero bellissime e ricchissime donne, giunte da paesi molto lontani. A Laconi le janas sono simili alle pana: le anime delle donne morte di parto, che si riuniscono sulle rive dei fiumi e lavano i panni dei loro neonati. Secondo alcune leggende, le Janas possedevano telai d’oro. Uno di questi sarebbe custodito nell’affascinante quanto tenebrosa gola di Gorroppu e nel Supramonte di Orgosolo. A Tonara si narra che le janas tessevano reti magiche per catturare gli esseri umani, i quali diventavano prede della Jana Maista, la malefica regina delle janas, che succhiava loro il sangue.
Le Domus de Janas sono strutture sepolcrali preistoriche costituite da tombe scavate nella roccia tipiche della Sardegna prenuragica. Si trovano sia isolate che in grandi concentrazioni costituite anche da più di 40 tombe. Ne sono state scoperte più di 2.400, circa una ogni chilometro quadrato, e molte rimangono ancora da scavare. Sono sovente collegate tra loro a formare delle vere e proprie necropoli sotterranee. I corpi erano depositati in posizione fetale accanto agli averi che si credeva fossero necessari per il viaggio verso l’aldilà. Molti credono che i defunti venissero posizionati in quel modo solo dopo essere stati lasciati all’aperto e, quando di loro rimaneva solo lo scheletro, venivano depositati nelle caverne.
Il termine di lingua sarda domus de janas è stato tradotto in "case delle fate".
Le janas sono infatti creature immaginarie della tradizione popolare sarda: donne incantatrici di minuscola statura che abitavano le Domus de Janas, scavate grazie alle loro forti e lunghe unghie. Sono le protagoniste di svariati racconti popolari della Sardegna, dove non sempre vengono descritte come fate, bensì anche come streghe, maghe e vampiri. Si dice fossero creature per niente spirituali, ma demoni nel senso greco del termine daimon, ovvero esseri a metà strada fra il mondo umano e quello divino.
Le janas sono conosciute con una numerosa varietà di termini, caratteristica questa propria di molti altri personaggi fantastici isolani che rispecchia i particolarismi locali e la fervida immaginazione di chi visse e vive la terra sarda.
A Oniferi così, come a Nuoro, le janas erano streghe o maghe dannose per gli esseri umani. A Fonni le leggende sulle janas raccontano di esseri minuscoli sia di sesso femminile che di sesso maschile. Una delle loro peculiarità era la bellezza e venivano descritte come incantatrici. A Belvì si narra che le janas fossero bellissime e ricchissime donne, giunte da paesi molto lontani. A Laconi le janas sono simili alle pana: le anime delle donne morte di parto, che si riuniscono sulle rive dei fiumi e lavano i panni dei loro neonati. Secondo alcune leggende, le Janas possedevano telai d’oro. Uno di questi sarebbe custodito nell’affascinante quanto tenebrosa gola di Gorroppu e nel Supramonte di Orgosolo. A Tonara si narra che le janas tessevano reti magiche per catturare gli esseri umani, i quali diventavano prede della Jana Maista, la malefica regina delle janas, che succhiava loro il sangue.
Reynisfjara
Nascosta tra i ghiacci, le nevi e i vulcani d’Islanda si trova una delle spiagge più spettacolari del mondo. Reynisfjara è una delle meraviglie naturali dell'isola, dove la sabbia è nera come la notte e il litorale è puntellato da ciottoli tondi levigati dall’azione incessante del mare. Sullo sfondo, le colonne basaltiche di forma geometrica della scogliera Reynisfjall, il promontorio di Dyrhòlaey e i faraglioni di roccia lavica immersi nella nebbia (che secondo la leggenda sarebbero due troll, sorpresi dalla luce albeggiante del sole mentre erano intenti a trasportare una nave e quindi trasformati in pietra).
La spiaggia è completamente nera a causa della cenere e dei detriti di origine vulcanica prodotti dall'erosione. L’intera spiaggia di si è creata in un lasso di tempo brevissimo durante l’ultima eruzione del vulcano Katla, il più temuto e pericoloso d’Islanda.
Nascosta tra i ghiacci, le nevi e i vulcani d’Islanda si trova una delle spiagge più spettacolari del mondo. Reynisfjara è una delle meraviglie naturali dell'isola, dove la sabbia è nera come la notte e il litorale è puntellato da ciottoli tondi levigati dall’azione incessante del mare. Sullo sfondo, le colonne basaltiche di forma geometrica della scogliera Reynisfjall, il promontorio di Dyrhòlaey e i faraglioni di roccia lavica immersi nella nebbia (che secondo la leggenda sarebbero due troll, sorpresi dalla luce albeggiante del sole mentre erano intenti a trasportare una nave e quindi trasformati in pietra).
La spiaggia è completamente nera a causa della cenere e dei detriti di origine vulcanica prodotti dall'erosione. L’intera spiaggia di si è creata in un lasso di tempo brevissimo durante l’ultima eruzione del vulcano Katla, il più temuto e pericoloso d’Islanda.
Cultura popolare
L'uovo di Sarnano
Il 21 novembre 1986, dopo giorni di forti piogge, nel torrente Terro nei pressi di Sarnano, fu ritrovato un grande uovo di calcare bianco con una vaschetta circolare scavata sulla sommità. Alto 120 centimetri e pesante tre tonnellate, il monolite fu sistemato in Piazza Alta, per poi essere spostato, in tempi più recenti, all’interno del polo museale di Sarnano.
Oggi è noto come Pietra di Terro o Uovo di Sarnano ed è considerato un reperto archeologico di grandissimo valore. Su di esso si sono interrogati in molti: che cos’è? A che epoca risale? Qual era il suo utilizzo?
Negli anni sono state avanzate diverse ipotesi. All’inizio si pensava fosse un cippo romano di epoca augustea, ma il catino scavato sulla sommità rendeva poco plausibile questa spiegazione.
L’altra ipotesi, più seguita, lo identifica come un manufatto di origine celtica. Sulla base dell’ipotesi celtica sono state elaborate due interpretazioni dell’Uovo di Sarnano. Entrambe lo collocano nella tradizione magico-rituale risalente a tempi antichissimi che ancora sopravvive nella cultura popolare dei Sibillini.
Una delle interpretazioni viene dalla scrittrice Joyce Lussu, secondo la quale l’Uovo veniva utilizzato per scegliere le coltivazioni più feconde. La vaschetta veniva riempita di semi e il primo che germogliava indicava la coltura che avrebbe dato maggiori frutti nel corso dell’anno.
L’altra interpretazione dell’Uovo di Sarnano, invece, viene dal Prof. Manlio Farinacci di Terni che, facendo il confronto con altri reperti simili ritrovati in Umbria e in Toscana, giunge alla conclusione che questi manufatti venivano utilizzati come osservatori astronomici. In pratica, la vaschetta veniva riempita d’acqua in modo da riflettere la posizione delle stelle e dei pianeti. Secondo Farinacci, il risultato più illustre di queste osservazioni dei druidi è il noto calendario astronomico di Coligny. Questo reperto, oggi conservato a Lione, ci ha permesso di apprendere il sistema di misurazione del tempo in uso presso i popoli celtici.
Il 21 novembre 1986, dopo giorni di forti piogge, nel torrente Terro nei pressi di Sarnano, fu ritrovato un grande uovo di calcare bianco con una vaschetta circolare scavata sulla sommità. Alto 120 centimetri e pesante tre tonnellate, il monolite fu sistemato in Piazza Alta, per poi essere spostato, in tempi più recenti, all’interno del polo museale di Sarnano.
Oggi è noto come Pietra di Terro o Uovo di Sarnano ed è considerato un reperto archeologico di grandissimo valore. Su di esso si sono interrogati in molti: che cos’è? A che epoca risale? Qual era il suo utilizzo?
Negli anni sono state avanzate diverse ipotesi. All’inizio si pensava fosse un cippo romano di epoca augustea, ma il catino scavato sulla sommità rendeva poco plausibile questa spiegazione.
L’altra ipotesi, più seguita, lo identifica come un manufatto di origine celtica. Sulla base dell’ipotesi celtica sono state elaborate due interpretazioni dell’Uovo di Sarnano. Entrambe lo collocano nella tradizione magico-rituale risalente a tempi antichissimi che ancora sopravvive nella cultura popolare dei Sibillini.
Una delle interpretazioni viene dalla scrittrice Joyce Lussu, secondo la quale l’Uovo veniva utilizzato per scegliere le coltivazioni più feconde. La vaschetta veniva riempita di semi e il primo che germogliava indicava la coltura che avrebbe dato maggiori frutti nel corso dell’anno.
L’altra interpretazione dell’Uovo di Sarnano, invece, viene dal Prof. Manlio Farinacci di Terni che, facendo il confronto con altri reperti simili ritrovati in Umbria e in Toscana, giunge alla conclusione che questi manufatti venivano utilizzati come osservatori astronomici. In pratica, la vaschetta veniva riempita d’acqua in modo da riflettere la posizione delle stelle e dei pianeti. Secondo Farinacci, il risultato più illustre di queste osservazioni dei druidi è il noto calendario astronomico di Coligny. Questo reperto, oggi conservato a Lione, ci ha permesso di apprendere il sistema di misurazione del tempo in uso presso i popoli celtici.
Architetture naturali
Nido di uccello giardiniere
Una curiosa caratteristica dell'uccello giardiniere è il complesso comportamento dei maschi, che costruiscono un nido per attirare le femmine anziché usare il piumaggio appariscente o un richiamo. Il nido può variare da un cerchio di terra con un piccolo mucchio di ramoscelli nel centro ad una complessa e altamente decorata struttura di bastoni e di foglie, intorno al quale il maschio pone una serie di oggetti da lui raccolti. Questi oggetti - in genere molto colorati - possono comprendere centinaia di conchiglie, foglie, fiori, piume, pietre, frutti di bosco, e anche oggetti di rifiuto di plastica o pezzi di vetro di colore blu. L’uccello poi organizza la sua raccolta, e se un oggetto viene spostato mentre è lontano egli lo metterà di nuovo al suo posto.
Una curiosa caratteristica dell'uccello giardiniere è il complesso comportamento dei maschi, che costruiscono un nido per attirare le femmine anziché usare il piumaggio appariscente o un richiamo. Il nido può variare da un cerchio di terra con un piccolo mucchio di ramoscelli nel centro ad una complessa e altamente decorata struttura di bastoni e di foglie, intorno al quale il maschio pone una serie di oggetti da lui raccolti. Questi oggetti - in genere molto colorati - possono comprendere centinaia di conchiglie, foglie, fiori, piume, pietre, frutti di bosco, e anche oggetti di rifiuto di plastica o pezzi di vetro di colore blu. L’uccello poi organizza la sua raccolta, e se un oggetto viene spostato mentre è lontano egli lo metterà di nuovo al suo posto.
Alga Marimo
Aegagropila linnaei è un'alga verde pluricellulare appartenente alla famiglia delle Cladophoraceae, diffusa nell'emisfero boreale. ll botanico giapponese Tatsuhiko Kawakami, nel 1820 le ha dato il nome di Marimo, ovvero “alga palla”. “Mari” significa biglia e “Mo” in giapponese è un termine generico per indicare le piante che crescono in acqua.
Quest’alga d’acqua dolce dalla caratteristica forma sferica, ha una crescita molto lenta quasi impercettibile, dai 5mm ai 10mm l’anno, e può essere grande dai 3cm fino ai 10 cm. Solo tre laghi al mondo hanno le caratteristiche ideali per poter accogliere le colonie di Marimo, e si trovano rispettivamente in Estonia, Islanda e in Giappone.
La leggenda del Marimo nasce da una bellissima storia d’amore; credo proprio che questo sia uno dei motivi principali che spinga più volentieri ad “adottare” questa buffa alga palla. La storia narra di due giovani innamorati, che per coltivare il loro amore fuggirono dalle proprie famiglie contrarie alla loro unione, un po’ in stile Romeo e Giulietta. Si trovarono così sulla sponda del lago Akan in Giappone, e i loro cuori, per rimanere insieme per sempre, si trasformarono nella rara sfera di Marimo. Questa alga infatti, può vivere fino ai 200 anni e dal 1921 è diventata tesoro naturale giapponese per evitarne l’estinzione.
Da qui nasce l’idea di considerarla una pianta portafortuna e che sia un regalo di buon auspicio portatore di felicità e amore.
Aegagropila linnaei è un'alga verde pluricellulare appartenente alla famiglia delle Cladophoraceae, diffusa nell'emisfero boreale. ll botanico giapponese Tatsuhiko Kawakami, nel 1820 le ha dato il nome di Marimo, ovvero “alga palla”. “Mari” significa biglia e “Mo” in giapponese è un termine generico per indicare le piante che crescono in acqua.
Quest’alga d’acqua dolce dalla caratteristica forma sferica, ha una crescita molto lenta quasi impercettibile, dai 5mm ai 10mm l’anno, e può essere grande dai 3cm fino ai 10 cm. Solo tre laghi al mondo hanno le caratteristiche ideali per poter accogliere le colonie di Marimo, e si trovano rispettivamente in Estonia, Islanda e in Giappone.
La leggenda del Marimo nasce da una bellissima storia d’amore; credo proprio che questo sia uno dei motivi principali che spinga più volentieri ad “adottare” questa buffa alga palla. La storia narra di due giovani innamorati, che per coltivare il loro amore fuggirono dalle proprie famiglie contrarie alla loro unione, un po’ in stile Romeo e Giulietta. Si trovarono così sulla sponda del lago Akan in Giappone, e i loro cuori, per rimanere insieme per sempre, si trasformarono nella rara sfera di Marimo. Questa alga infatti, può vivere fino ai 200 anni e dal 1921 è diventata tesoro naturale giapponese per evitarne l’estinzione.
Da qui nasce l’idea di considerarla una pianta portafortuna e che sia un regalo di buon auspicio portatore di felicità e amore.
Arte
|
Il pañuelo nella danza
Il pañuelo è un fazzoletto di tela quadrato e viene generalmente utilizzato come oggetto di uso personale. Inoltre, viene utilizzato in molte danze tradizionali di orgine sudamericana (in Argentina per ballare la zamba; in Chile e Bolivia per la cueca; in Perù per la marinera; in Uruguay per il Pericon Nacional; in Colombia per bambuco, cumbia, mazurca e galeròn). Così come il ventaglio nella tradizione del flamenco, il pañuelo nel contesto della danza viene utilizzato come estensione del corpo, come strumento per una comunicazione silenziosa, dettata dal solo movimento. |
|
Cueca sola
La cueca sola è una variazione della cueca, creata dalla Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) del Chile, organizzazione fondata a seguito del golpe militare del 1973 in Chile. Questa variante della cueca presenta la particolarità di essere ballata solamente da una donna, senza un partner - come è invece solito in qualunuque altra variante della cueca - che porta con sé un ritratto della persona che vuole ricordare. Il ritmo e la musica nella danza sono identici, ma i versi della cueca manifestano il dolore per la perdita di una persona cara ai tempi della dittatura. |
Rebecca Horn , body extensions
Musica
Tonada de Luna Llena , Simon Díaz
Tonada de luna llena es el título de una canción del artista venezolano Simón Díaz, grabada para el álbum Tonadas, de 1973.
Durante los años cincuenta, el género musical de tonadas, comúnmente asociadas a los ordeñadores de vacas, corría el riesgo de desaparecer junto con la tradicional profesión. Al advertir esto, Díaz comienza a componer canciones del género a fin de mantenerlo vivo en la cultura venezolana e hispanoamericana.
Yo ví de una garza mora
Dandole combate a un rio
Asi es como se enamora
Tu corazon con el mio
Luna luna luna llena
Menguante
Anda muchacho a la casa
Y me traes la carabina jiooo
Pa mata este gavilan
Que no me deja gallina
La luna me esta mirando
Yo no se lo que me ve
Yo tengo la ropa limpia
Ayer tarde la lave
Luna luna luna llena
Menguante
Tonada de luna llena es el título de una canción del artista venezolano Simón Díaz, grabada para el álbum Tonadas, de 1973.
Durante los años cincuenta, el género musical de tonadas, comúnmente asociadas a los ordeñadores de vacas, corría el riesgo de desaparecer junto con la tradicional profesión. Al advertir esto, Díaz comienza a componer canciones del género a fin de mantenerlo vivo en la cultura venezolana e hispanoamericana.
Yo ví de una garza mora
Dandole combate a un rio
Asi es como se enamora
Tu corazon con el mio
Luna luna luna llena
Menguante
Anda muchacho a la casa
Y me traes la carabina jiooo
Pa mata este gavilan
Que no me deja gallina
La luna me esta mirando
Yo no se lo que me ve
Yo tengo la ropa limpia
Ayer tarde la lave
Luna luna luna llena
Menguante
Ut queant laxis
Ut queant laxis è l'inno liturgico dei Vespri della solennità della natività di San Giovanni Battista che ricorre il 24 giugno.
La fama di questo inno di strofe saffiche, scritto dal monaco storico e poeta Paolo Diacono, si deve a Guido d'Arezzo, che ne utilizzò la prima strofa per trarne i nomi delle sei note dell'esacordo; A ciascuna sillaba qui evidenziata corrisponde infatti, nella musica dell'inno, la relativa nota con cui è cantata. Da tale criterio convenzionale derivano tuttora i nomi delle note musicali: Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La.
Ut queant laxis è l'inno liturgico dei Vespri della solennità della natività di San Giovanni Battista che ricorre il 24 giugno.
La fama di questo inno di strofe saffiche, scritto dal monaco storico e poeta Paolo Diacono, si deve a Guido d'Arezzo, che ne utilizzò la prima strofa per trarne i nomi delle sei note dell'esacordo; A ciascuna sillaba qui evidenziata corrisponde infatti, nella musica dell'inno, la relativa nota con cui è cantata. Da tale criterio convenzionale derivano tuttora i nomi delle note musicali: Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La.